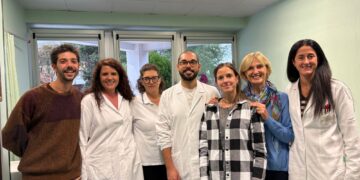Arnaldo Pomodoro ci ha lasciati lo scorso 22 giugno, poco prima dello scoccare del suo novantanovesimo compleanno. La risonanza mediatica di questa perdita rende una vaga idea della portata e dell’impatto che il suo lavoro di scultore ha avuto in diversi, ampi e vasti settori della società globale. Certo, l’essere fra i pochi, pochissimi artisti ad essere rappresentati con importanti e iconici interventi ambientali nei cinque continenti ha contribuito al suo riconoscimento internazionale. Fra il grande pubblico, l’alternanza, nelle grandi sculture sferiche, di superfici metalliche lisce e di voragini scavate e intessute di squarci e sconnessioni, costituisce un riferimento visivo immediatamente riconoscibile: Pomodoro è stato ed è per moltissimi di noi la lucentezza splendente delle superfici del bronzo lucidato (e mai patinato), il conturbante arcaico della materia scavata e misteriosamente metamorfica, e quel contrappunto indissolubile tra i due valori plastici. La sensazione sottopelle è quella di uno sguardo che ci viene concesso osare – perché invitati, accolti dalla dimensione pubblica del suo lavoro – sopra un processo intimo, di generazione o gestazione di segni embrionali che nascono da una autonoma organizzazione interna della materia. Una scultura eroica ma mai trionfale, che si interroga e ci interroga piuttosto con quella vena di inquietudine propria delle immagini conturbanti.
Questa, in effetti, può essere una sintesi del suo lavoro plastico: l’immagine più frequente di Pomodoro (nei tanti meravigliosi video di documentazione che la sua Fondazione di Milano ha archiviato e reso pubblici sul proprio sito) è infatti quella di un uomo (corporatura asciutta, agile e muscolosa, mediterranea) immerso nel guscio delle forme che riempiva e svuotava di materia. Mani e braccia che spingono, staccano, battono, tagliano la creta, per creare fitti intrichi di vettori geometrici, che via via si fanno segni astratti, infine simbolici; affilati e ritmati, soprattutto, nella partitura totale della scultura. Pomodoro alternava il lavoro con la creta a quello con le impalcature di legno, argani di forme, contrafforti, staffe che egli si costruiva da sé, sempre con il pensiero orientato a quella sua ossessione processuale di lavorare al contrario, di scavare cioè la materia per sottrazione, in negativo, lasciando che fosse poi il metallo fuso, una volta rimossa la struttura di legno o gesso, a riempire i vuoti, gli spazi, che egli non aveva mai visto nella loro interezza (con qualche passaggio intermedio in più, tutto lavoro cui egli non ha mai abdicato, pur circondandosi di necessari e validissimi collaboratori).
Nascevano così superfici e conformazioni letteralmente venute dalla dimensione dell’invisibile.
Vastissima la sua letteratura critica, eppure solo talvolta ci si è interrogati e prodigati in interpretazioni sul perché Arnaldo si fosse fissato su questa complessa, davvero onerosa e faticosa operazione in più passaggi, per ottenere infine un’opera che necessitava di lavorare in modo reiterato per partire dal negativo. Non soltanto per me, ma per chi gli è stato più vicino nel lavoro, e quindi nella parte più profonda della sua vita da artista, questo rimane un mistero. Sappiamo però dove l’intuizione ha avuto origine: il giovanissimo Arnaldo Pomodoro (nato nel Montefeltro il 23 giugno 1926) si reca a bottega nel “buco di un orafo” di Pesaro, iniziando a incidere gli ossi di seppia che, come è noto, costituiscono il medium privilegiato degli artigiani dei gioielli in metallo. È allora che avviene la folgorazione verso quel materiale organico, che si fa strumento al tempo stesso, con cui il giovane artista realizza i suoi primi rilievi scultorei in argento, ottenuti dalla fusione del metallo direttamente nei solchi incisi in negativo nell’osso di seppia.
Quando, nel 1966, si recò a insegnare scultura all’Università di Berkeley, poi seguita da Stanford e da altri istituti della Bay Area, acquisì conoscenze tecniche ma soprattutto mutò sguardo – grazie ai grandi spazi americani – e interiorizzò il metodo di insegnamento democratico e sperimentale erede del Black Mountain College e quindi del Bauhaus. Come conseguenza, a Pietrarubbia nel 1991 fondò il TAM, la Scuola di Trattamento Artistico dei Metalli, dove in un clima di amicizia e condivisione si insegnavano ai più giovani le tecniche per la lavorazione dei metalli plastici. Sulla stessa scia, Pomodoro ha voluto e organizzato la Fondazione milanese che porta il suo nome: un’istituzione culturale che è da molti anni un modello per il suo grande e costante lavoro educativo e divulgativo intorno al rispetto e all’amore per le tecniche e i materiali scultorei, per il suo sostegno ai giovani artisti contemporanei e, naturalmente, per il suo irreprensibile lavoro di tutela, studio e promozione del lavoro di Pomodoro.
Personalmente l’ho incontrato in tre occasioni: quando studiavo all’Università e mi crucciavo fra sogni e incertezze – e quei pochi minuti di dialogo vero mi segnarono e ancora li ricordo; quando molti anni più tardi gli feci visita con Roberta Baj nello studio di Milano; e infine quando, pochi mesi fa, pur senza vederlo mai di persona, naturalmente, ho potuto lavorare con le sue opere nell’ultima e recente mostra monografica De-Rive, insieme alle molte persone (colleghe e colleghi cresciuti da Arnaldo) che lavorano nell’archivio, nell’officina, nel laboratorio creativo e scientifico della sua Fondazione, a partire dalla nipote Carlotta Montebello, alla quale è andato il primo pensiero e che della Fondazione è direttrice generale. A volte si parlava anche dell’imminente centenario, che sarebbe caduto l’anno prossimo, ma per il resto ci si confrontava e raccontava all’infinito intorno alla moltitudine di progetti, processi, e documenti conservati nel grande archivio e generati da quest’uomo che ha davvero trasformato il mondo che lo circondava, e anche un bel po’ di mondo più lontano di noi.
Per queste ragioni ritengo che non ci abbia lasciato l’ultimo gigante del Novecento, o sicuramente un pezzo molto importante dell’arte e della cultura del nostro tempo. Non se n’è andato perché il suo grande lavoro artistico e il suo lungo impegno didattico e culturale sono germinati talmente tanto da rendere vive, oggi più che mai, le sue idee e le sue opere.
Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea, dipartimento di Culture e civiltà