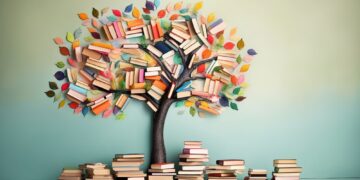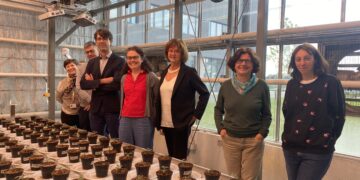Con la scomparsa di papa Francesco si chiude una delle stagioni più intense e significative della storia recente della Chiesa cattolica. Primo papa gesuita e sudamericano, Jorge Mario Bergoglio ha portato avanti un pontificato segnato da empatia, apertura e voglia di cambiamento. La sua voce, spesso fuori dal coro, è riuscita a farsi sentire ovunque: dalle periferie dimenticate ai grandi palazzi del potere, con un messaggio di pace, misericordia e inclusione.
Ne parliamo con Giuseppe Comotti, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche e referente del Magnifico Rettore per i rapporti con le istituzioni religiose.
Professore, papa Francesco è stato spesso descritto come un “rivoluzionario”. In che modo è cambiata la percezione di questa figura istituzionale nel mondo di oggi?
È innegabile che papa Francesco sia andato ben oltre il ruolo di un leader religioso, seppur a capo di una comunità, quale la Chiesa cattolica, che supera il miliardo di fedeli nel mondo. Passata l’emozione inevitabilmente prodotta dalla scomparsa di un personaggio pubblico che ha accompagnato da protagonista la vita dell’umanità degli ultimi dodici anni, ci sarà modo, al di là del credo religioso di ciascuno, di approfondire la ricchezza dell’eredità che ha lasciato, soprattutto in tema di giustizia sociale, di attenzione agli ultimi, di difesa dell’ambiente, di dialogo tra culture e religioni. Resta come eredità preziosa soprattutto il suo impegno infaticabile ed accorato per la pace e suonano come un monito le parole del suo messaggio pasquale urbi et orbi, poche ore prima della morte: «Nessuna pace è possibile laddove non c’è libertà religiosa o dove non c’è libertà di pensiero e di parola e il rispetto delle opinioni altrui».
Bergoglio ha sempre mostrato una grande attenzione per i giovani. Che tipo di rapporto aveva con il mondo universitario e con l’istruzione in generale? E che visione aveva del rapporto tra scienza e fede?
Una delle sue frasi più ricorrenti negli incontri con i giovani era: «Non lasciatevi rubare la speranza!». Non si trattava di un semplicistico invito a guardare al futuro con ottimismo, nonostante i gravi problemi che agitano il mondo, ma a farsi protagonisti di un cambiamento realmente possibile, mediante l’impegno responsabile di ciascuno. In questa prospettiva, papa Francesco ha sempre guardato all’Università come ad un luogo di crescita del sapere quale strumento a servizio dell’umanità e del bene comune. Credo resti una rarità nel panorama degli interventi pontifici il messaggio inviato al Magnifico Rettore neppure tre mesi fa, in occasione dell’ultima inaugurazione dell’anno accademico del nostro Ateneo, nel quale papa Francesco ha appunto ricordato che «non si tratta di moltiplicare le nozioni e le teorie, ma di fare della formazione accademica uno spazio vitale, che comprende la vita e parla alla vita» e che «è responsabilità dell’Università promuovere una cultura aperta per evitare che sia “settaria” e si ponga al di sopra degli altri […] Una cultura fatta con il cuore: l’Università è un luogo la cui missione si deve esprimere attraverso l’azione formativa eseguita con grande passione. Una cultura radicata nel dialogo e nell’incontro: poiché in ogni istituzione i diversi saperi si incontrano e si arricchiscono reciprocamente, superando la frammentazione della conoscenza. È importante perciò promuovere un’educazione che sappia “connettere” invece che “separare”. Una cultura di differenze: l’Università è chiamata a essere custode di diversità, riconoscendo che il vero dialogo culturale non mira a una omogeneizzazione del pensiero, ma valorizza la specificità di ogni tradizione e prospettiva».
Ha un ricordo personale legato a lui? Un incontro, una parola, un gesto che le è rimasto impresso?
Negli anni mi è capitato diverse volte di essere invitato a cena nella “Domus Sanctae Marthae”, dove risiedeva papa Francesco. In quelle occasioni, ho potuto notare che, nella quotidianità del privato, il papa accentuava ulteriormente la semplicità di stile che ha sempre caratterizzato le sue apparizioni in pubblico: cenava nella sala comune e si accostava anch’egli, come gli altri, al self-service ed aveva sempre un’attenzione particolare per il personale di servizio, che ringraziava e salutava per nome prima di uscire.
Sara Mauroner