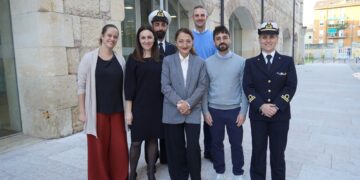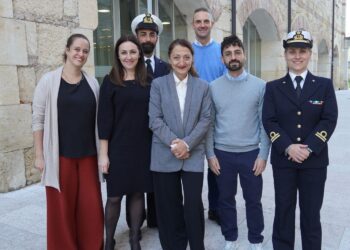Negli ultimi anni il rincaro dei prezzi ha colpito con particolare durezza la spesa alimentare delle famiglie italiane, erodendo in modo significativo il loro potere d’acquisto. Non è la prima volta che l’Italia affronta ondate inflazionistiche: dagli shock petroliferi degli anni Settanta all’introduzione dell’euro, fino alla crisi finanziaria del 2008-2009, il nostro Paese conosce bene gli effetti di un aumento generalizzato dei prezzi. Tuttavia, ciò che stiamo vivendo oggi ha contorni diversi: non un semplice ciclo economico sfavorevole, ma un vero e proprio shock multidimensionale che intreccia crisi sanitarie, geopolitiche, energetiche e climatiche.
È quanto emerso nella puntata del programma Forum economia “La spesa in salita”, condotta dal giornalista Lucio Salgaro, andata in onda giovedì 20 novembre su Telearena, che ha riunito attorno allo stesso tavolo Roberta Capitello, docente di Economia agraria all’Università di Verona, Matteo Ostengo di Adiconsum Verona, Alberto De Togni di Confagricoltura Verona, Michele Rossetto del Gruppo Supermercati Rossetto. Un confronto ricco e necessario per tentare di leggere un fenomeno complesso che coinvolge consumatori, imprese e istituzioni.
L’editoriale di Roberta Capitello, docente di Economia agraria, agroalimentare ed estimo rurale nel dipartimento di Management
Dal 2021, i prezzi dei prodotti alla base della nostra dieta mediterranea – frutta, verdura, cereali, latte, formaggi, uova – sono aumentati fino al 20-30%. A spiegare questa impennata non è un solo fattore. La pandemia da COVID-19 ha provocato una discontinuità dal lato dei consumi alimentari, dovuta al periodo di lockdown e alla chiusura delle attività fuori casa, ma anche dal lato dell’offerta, a causa del rallentamento delle attività produttive e delle difficoltà di ripresa dei commerci, provocando inevitabilmente un aumento dei prezzi nel periodo della “nuova normalità”. Anche gli anni successivi, dal 2022, non sono stati favorevoli a seguito delle problematiche geopolitiche e di conflitto che hanno riguardato paesi quali la Russia e l’Ucraina, tra i principali fornitori dell’Europa di materie prime agricole e risorse energetiche.
L’impatto sui flussi produttivi e sugli scambi, accompagnato da un diffuso clima di incertezza e sfiducia, ha favorito l’aumento dei prezzi dell’energia, andando a cascata a colpire negativamente tutte le filiere agroalimentari fino al consumatore con l’aumento generalizzato dei prezzi finali dei beni alimentari. Molte sono infatti le materie prime, i materiali di consumo e le fonti energetiche il cui aumento di prezzo ha impattato negativamente sui costi delle imprese dell’agroalimentare. Si pensi, ad esempio, all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e alla conseguente crescita dei costi per l’industria dei prodotti da forno, oppure all’aumento dei prezzi dei cereali importati e alle conseguenze negative sui costi per gli allevamenti e le filiere produttive di carne, latte, formaggi e uova.
A ciò si aggiunge la volatilità dei mercati agroalimentari da sempre soggetti al clima, ma oggi sottoposti ad eventi avversi sempre più intensi e a rischi di diffusione di malattie nelle coltivazioni o negli allevamenti, che causano riduzione dell’offerta e instabilità di mercato, come sta avvenendo, ad esempio, nei mercati del caffè e del cacao. Le politiche protezionistiche in discussione rappresentano un ulteriore elemento di timore verso la crescita dei prezzi anche per il futuro.
In questo scenario, i più penalizzati restano i consumatori, posizionati all’ultimo anello della filiera, si trovano in una situazione di debolezza dato che assistono impotenti a tutti gli aumenti di prezzo che si riversano verso valle. Alcuni consumatori più di altri soffrono questa situazione. Sono i consumatori con il reddito più basso, dato che per essi, essendo la spesa alimentare una voce difficilmente comprimibile del proprio bilancio familiare andando a coprire necessità primarie, l’aumento dei prezzi provoca una riduzione del potere d’acquisto a scapito di altre voci di spesa altrettanto importanti, quali le prestazioni sanitarie.
Sono in una situazione di debolezza anche le imprese poste all’inizio della filiera produttiva, quali le imprese agricole, e quelle di minore dimensione, dato che hanno più ridotti spazi di manovra nella gestione dei prezzi a monte e di potere contrattuale a valle, oltre che maggiori difficoltà nell’attuare investimenti migliorativi in termini di efficienza, ad esempio, energetica.
Le conseguenze inflazionistiche non generano solo gli attuali problemi di natura economica, ma si riversano nel medio e lungo termine con problematiche di tipo sociale e pubblico. Infatti, sulla domanda, l’inflazione svolge anche un pesante effetto di sostituzione. I prodotti che subiscono i maggiori rincari sono quelli alla base della nostra dieta mediterranea e delle filiere di produzione nazionali, quali ortofrutta, pane, uova, latte. Sono gli ingredienti principali per pasti salutari perché sono freschi e ricchi di nutrienti quali proteine, carboidrati e vitamine. In una situazione difficile come quella attuale, il consumatore alla ricerca di servizio e di convenienza di prezzo viene spesso attratto dai cosiddetti prodotti ultraprocessati caratterizzati da alti contenuti di nutrienti complessi, spesso sbilanciati negli apporti di zuccheri e grassi, e calorie. Risultando “convenienti” nel rapporto prezzo-calorie, sono spesso preferiti nella scelta alimentare, andando però a sviluppare una problematica che non è più solo economica, ma anche di tipo personale e sociale, per la crescente incidenza di malattie non trasmissibili legate alla malnutrizione, che si traducono nel lungo periodo in maggiori costi individuali e collettivi.
Proprio per rispondere a queste sfide, all’interno del dipartimento di Management, insieme con altri ricercatori dell’ateneo, stiamo lavorando su questo tema attuale delle scelte alimentari nella più ampia prospettiva della sostenibilità attraverso un progetto di ricerca chiamato FoodMission finanziato dall’Unione Europea. Con il lavoro congiunto di altre università europee e di sviluppatori di tecnologie digitali, l’Università di Verona sta contribuendo alla creazione di una piattaforma digitale per accrescere conoscenze e responsabilità delle persone verso una scelta alimentare più sostenibile nel senso più ampio del termine, ovvero attenta non solo agli impatti ambientali ma anche a quelli sulla salute e benessere collettivo, nonché accessibile in termini economici.
EI
estratto video per gentile concessione del Gruppo Athesis
Forum economia, puntata del 20 novembre 2025, Telearena