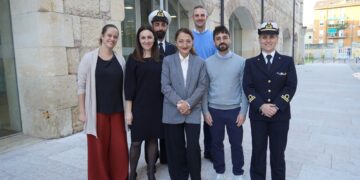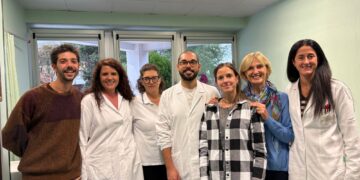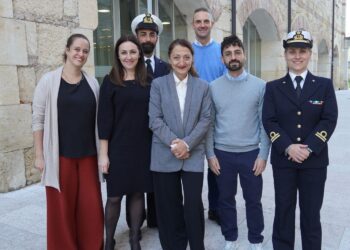Succede più spesso di quanto pensiamo. Una collega che smette di sorridere, un amico che si isola, un familiare che dice “mi sento solo un po’ giù”, ma in realtà sta lottando e soffrendo ogni giorno. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, una persona su otto nel mondo sperimenta almeno un disturbo mentale nel corso della vita. Non si tratta di un’eccezione, ma di una realtà diffusa, che riguarda tutti.
I problemi di salute mentale sono frequenti e in costante aumento. In Italia le patologie più comuni sono ansia e depressione, che arrivano a riguardare il 15% della popolazione ultra sessantacinquenne. Negli anni post-Covid, un dato preoccupante è il continuo incremento di disturbi del sonno, disturbi dell’alimentazione e uso problematico di sostanze, soprattutto nei giovani adulti.
Di questi argomenti, e in particolare di come rispondere al meglio ai bisogni delle persone con problemi di salute mentale, si è discusso lo scorso 11 ottobre presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. L’evento, organizzato dai docenti di Psichiatria e Psicologia clinica dell’Università di Verona e dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata, e patrocinato dal Comune di Verona, ha individuato tre temi chiave.
A livello di cittadinanza, è necessario aumentare la consapevolezza che la salute non si esaurisce nell’assenza di malattie ma include il benessere emotivo. Spesso l’accesso alle cure per problemi di salute mentale è ritardato dalla difficoltà di riconoscere il disagio emotivo, ma anche dalla vergogna e dallo stigma associato all’idea di avere un problema di salute mentale. Vari studi hanno documentato che oltre il 50% delle persone con un disturbo mentale non hanno cercato supporto per timore di come sarebbero state percepite dagli altri. In realtà, tanto più precoce è il riconoscimento e l’intervento, tanto più l’esito sarà favorevole. Una ricerca appena conclusa all’Università di Verona ha analizzato il “gap terapeutico” nei servizi di salute mentale, ovvero la quota di persone che, pur necessitando di un trattamento, non lo ricevono. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Lancet Regional Health Europe, hanno evidenziato una carenza ampia e diffusa dei servizi psichiatrici europei nella capacità di intercettare chi ha bisogno di cura, confermando l’importanza di un riconoscimento tempestivo del disagio e del suo adeguato orientamento verso i servizi competenti.
Un secondo aspetto è che il nostro Paese ha un numero basso di professionisti della salute mentale per abitante, e questo si riflette in servizi sovraccarichi. In Italia operano circa 8 psichiatri ogni 100.000 abitanti, meno della metà rispetto a paesi come Francia, Paesi Bassi o Svezia, dove si superano i 20 specialisti per 100.000 abitanti. Porre rimedio non è facile, in quanto la carenza di professionisti in questo ambito riflette la più ampia carenza di medici e infermieri che riguarda molti settori dell’assistenza sanitaria in questo momento storico.
ll terzo tema-chiave riguarda il potenziamento della ricerca scientifica. La ricerca consente di comprendere meglio i fattori di rischio dei disturbi mentali, di valutare l’efficacia delle terapie e di sviluppare interventi sempre più mirati. È un elemento essenziale per far progredire la pratica clinica: senza ricerca, l’attività quotidiana dei servizi rischia di restare ferma; con la ricerca, invece, diventa possibile offrire cure più personalizzate ed efficaci.
Servono risorse, professionisti e ricerca scientifica. Ma serve anche un cambiamento culturale: capire che chiedere aiuto non significa essere deboli, ma avere il coraggio di prendersi cura di sé e degli altri.
Corrado Barbui, docente di Psichiatria e direttore del Centro organizzazione mondiale della sanità per la ricerca in salute mentale dell’Università di Verona
editoriale pubblicato sull’Arena del 4 novembre 2025