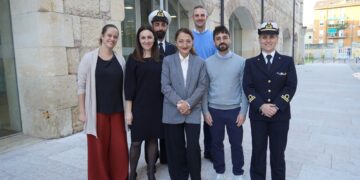Esattamente cinquant’anni fa, la firma del Trattato di Osimo da parte dell’Italia e della Jugoslavia rappresentava l’esito di un lungo processo che aveva condotto i due Paesi a riconoscere formalmente i loro confini come erano maturati nel secondo dopoguerra. All’epoca, il Trattato fu accolto dalle proteste di chi non si rassegnava alla perdita di territori precedentemente italiani. Eppure, l’evoluzione storica dell’area spiega l’impraticabilità di soluzioni alternative. Le politiche di italianizzazione promosse dal regime fascista durante il Ventennio avevano incrinato un tessuto sociale già plurilingue, mentre la Seconda Guerra Mondiale aveva trasformato l’Istria e Trieste in spazi contesi da eserciti occupanti e movimenti resistenziali, oltre che in un teatro di violenze e atrocità senza fine. Al termine del conflitto, gli Accordi di Belgrado stabilirono una divisione provvisoria tra Zona A (inclusa Trieste), sotto controllo alleato, e Zona B (gran parte dell’Istria), affidata alla Jugoslavia. Il successivo progetto di un territorio libero di Trieste, previsto dal Trattato di pace del 1947 e gestito dall’Onu, rimase inattuato per l’inasprimento dei rapporti tra le potenze vincitrici della guerra. Nello stesso periodo, violenze ed epurazioni indussero una parte significativa della comunità italiana a lasciare la Zona B, mentre nel 1954 il memorandum di Londra assegnò all’Italia l’amministrazione di Trieste e dell’intera Zona A.
Fu in questo quadro che si sviluppò un graduale percorso diplomatico che vide la parte più realista e responsabile della classe dirigente e della diplomazia italiana prendere atto dell’irreversibilità dell’assetto territoriale, considerato non modificabile né mediante pressioni politiche né attraverso iniziative unilaterali. La formazione dei governi di centrosinistra e la marginalizzazione delle correnti più intransigenti favorirono questa consapevolezza, mentre il particolare posizionamento internazionale della Jugoslavia — estranea all’ortodossia sovietica e sostenuta dall’Occidente per ragioni strategiche — incoraggiava Roma a ricomporre le vertenze ancora aperte.
Il clima di distensione che si diffuse in Europa negli anni ’70 incentivò la ricerca di un accordo. In particolare, la Ostpolitik condotta dal Cancelliere tedesco Willy Brandt si fondava sull’accettazione dei confini sorti dal conflitto mondiale come primo passo per la costruzione di relazioni Est-Ovest più cooperative. Il processo culminò nell’agosto del 1975, tre mesi prima del Trattato di Osimo, quando la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa radunò a Helsinki 35 paesi (inclusi l’Italia e la Jugoslavia) per la firma dell’Atto Finale, un decalogo che avrebbe dovuto regolare i rapporti tra gli Stati europei sulla base del rispetto delle frontiere, della sovranità altrui, della promozione della cooperazione e dei diritti umani.
Il Trattato di Osimo recepì tale impostazione: la linea di demarcazione delineata nel 1945 venne elevata a confine internazionale, mentre accordi complementari definirono strumenti di tutela delle minoranze e aprirono alla prospettiva di forme di cooperazione transfrontaliera. Sebbene molte di queste ultime previsioni non si tradussero subito in risultati concreti, l’intesa costituì la premessa essenziale per rapporti pacifici nel periodo successivo alla dissoluzione della Jugoslavia e all’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea. L’attuale permeabilità di quel confine, un tempo intensamente sorvegliato e oggi liberamente attraversabile, testimonia la lungimiranza di quella scelta politica.
Giovanni Bernardini
ricercatore di Storia contemporanea del dipartimento di Culture e civiltà